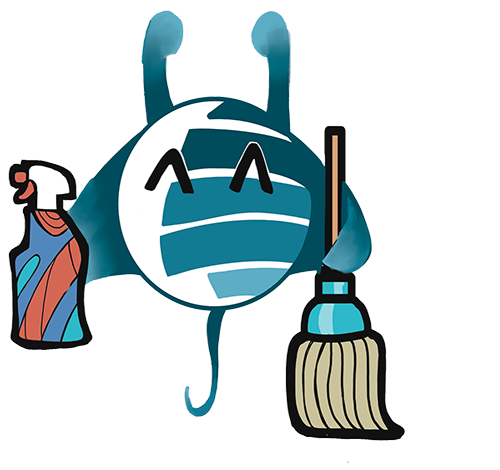Uno dei centri mondiali dello studio dei cambiamenti climatici a livello globale e del loro impatto sugli ambienti marini è il Golfo di Napoli, in virtù delle particolari caratteristiche geologiche di alcune sue aree.
In particolare, quelle di origine vulcanica, che si caratterizzano per la notevole complessità geomorfologica, rappresentata da canyon, isole, banchi rocciosi profondi e montagne sottomarine, a cui corrisponde una altrettanto grande complessità ecologica, giacchè vi sono concentrati tutti i principali ecosistemi esistenti, ciascuno con flora e fauna del tutto peculiari. Con il vantaggio di disporre già di un’amplissima banca dati, trattandosi del sito marino più studiato al mondo e senza soluzione di continuità da oltre 160 anni, considerato che nel 1872 Anton Dohrn fondò proprio a Napoli la Stazione Zoologica, motivato dalla straordinaria biodiversità del golfo ampiamente nota e dall’esistenza in città della più antica cattedra universitaria di Zoologia in Italia, attiva presso la “Federico II” dal 1848.
E se il golfo di Napoli è rappresentativo della varietà di ecosistemi dell’intero Mediterraneo, il mare che circonda le Isole Flegree – Ischia, Vivara e Procida – si configura a sua volta come un piccolo, perfetto esempio dell’intero golfo, proponendo perciò le condizioni ideali per lo studio degli effetti del cambiamento climatico sui diversi habitat marini. C’è da considerare, inoltre, che nel mare dell’arcipelago campano e delle vicine Isole Pontine passava fino a poco tempo fa il confine bio-geografico e climatico dell’isoterma dei 14 gradi, frontiera tra gli areali settentrionali e meridionali del bacino mediterraneo. L’innalzamento della temperatura del mare ha già prodotto lo spostamento di quel confine più a nord, in corrispondenza ora dell’arcipelago toscano, ma il mare flegreo è ancora un laboratorio naturale ideale per le rilevazioni statistiche e gli approfondimenti scientifici da parte di ricercatori provenienti da ogni parte del mondo.
L’acidificazione degli oceani
Tra i temi oggetto di studio vi è il progressivo abbassamento del ph marino su scala globale ad un ritmo senza precedenti negli ultimi 25 milioni di anni. D’altronde, è stato calcolato che ogni giorno gli oceani e i mari del pianeta assorbono ogni giorno 24 milioni di tonnellate di CO2, ovvero un terzo della produzione mondiale, che dall’inizio della rivoluzione industriale, intorno al 1850, è aumentata del 40 per cento. Nello stesso periodo, l’acidità dell’acqua di mare ha registrato un incremento del 26 per cento. A questo ritmo, la proiezione dell’aumento alla fine del secolo attuale è di un ulteriore 10 per cento.
La presenza nel mare di CO2 produce acido carbonico che, per una serie di fenomeni chimici provoca una forte riduzione del carbonato di calcio, elemento fondamentale per lo scheletro e i gusci degli organismi calcificanti di cui fa parte anche l’uomo. E questo rappresenta un problema per le specie calcificanti che si trovano a dover affrontare una carenza di questa sostanza per loro vitale, tantopiù in un ambiente sempre più acido.
I vents di Ischia
Per studiare l’acidificazione degli oceani e i suoi effetti sulle specie animali e vegetali marine, si utilizzano alcuni sistemi idrotermali già naturalmente acidificati che si trovano nel mare flegreo, davanti alla costa settentrionale dell’isola d’Ischia, lungo una faglia che lambisce il Castello Aragonese sul lato che guarda l’isola maggiore, e che poi prosegue davanti all’abitato di Ischia Ponte e alla successiva Spiaggia dei Pescatori. In quei punti si osservano in mare delle emissioni di CO2 dette vents, che provengono dalla camera magmatica profonda.
Il primo a essere individuato e studiato è stato il sito sotto il Castello Aragonese, che si trova a bassissima profondità, tanto da essere visibile anche a chi pratica lo snorkeling. Si tratta di un laboratorio al centro di numerosi progetti di ricerca, tanto da risultare il più studiato del Mediterraneo e ormai noto in tutto il mondo sia perché utilizzato da team di ricercatori di varie università e provenienze sia per il numero e l’importanza delle pubblicazioni che gli sono state dedicate sulle più importanti riviste scientifiche internazionali.
A quel primo sito si sono aggiunti gli altri dal 2014, quando furono identificati, anche sulla base delle segnalazioni di pescatori e subacquei, dal gruppo di ricerca della Stazione Zoologica di Napoli guidato dalla dottoressa Maria Cristina Gambi, che provvide a segnalarli con una comunicazione sul notiziario della Società Internazionale di Biologia Marina. Quei nuovi “possibili laboratori naturali per lo studio dell’acidificazione e cambiamento climatico a mare”, posti a profondità variabili tra i 2 e i 48 metri, si sono rivelati da allora particolarmente interessanti, in quanto ciascuno di essi presenta caratteristiche peculiari e riguarda sostrati e habitat diversi. Infatti, la cosiddetta “Vullatura”, dove le emissioni sono particolarmente visibili e finanche scenografiche, emerge da un fondale sabbioso su cui cresce la prateria di Posidonia; “Chiane del Lume” riguarda un sostrato roccioso con Posidonia, mentre la “Secca della Madonnina” di coralligeno è il sito più profondo, tra i 38 e i 48 metri. Dalla parte opposta del Castello Aragonese, inoltre, le emissioni riscontrate all’interno della Grotta del Mago rappresentano l’unico “vent” in grotta finora conosciuto.
Tutti gli studi finora completati hanno indicato in modo univoco, in quelle aree circoscritte, una regressione significativa delle specie sia vegetali che animali, dunque una perdita netta di biodiversità. In particolare, le specie animali calcificanti sono le più colpite dall’impatto con un ph più acido del normale.
Quella che sembra resistere è la Posidonia, che come pianta trasforma la CO2 con la fotosintesi, di fatto contrastando l’acidificazione, mentre la sua produzione di ossigeno salvaguarda la biodiversità, che riesce a conservarsi lì dove cresce la pianta.
Tuttavia, gli studi sui “vents” nei siti sottomarini naturalmente acidi continuano e non mancheranno di produrre altri preziosi risultati per conoscere in anticipo gli effetti dell’incremento dell’acidificazione del mare su scala globale.