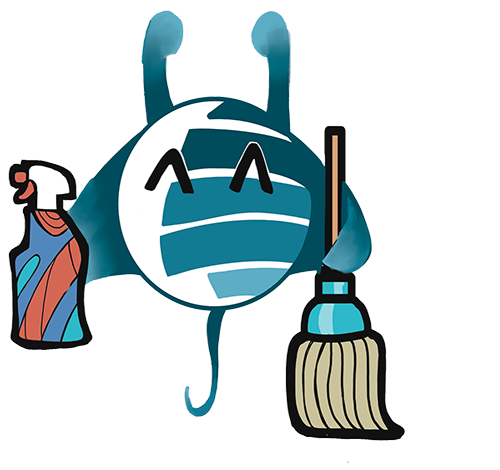Tra i diversi habitat che caratterizzano l’ambiente marino del Mediterraneo c’è anche quello delle grotte sommerse.
Anche se l’uso del singolare non è forse appropriato, considerate le differenze tra le grotte marine che punteggiano le coste della penisola e delle isole, a cominciare dalle loro origini e caratteristiche geologiche, per cui ogni cavità, anche rispetto ad altre nella stessa zona geografica, finisce con l’essere un unicum con peculiarità proprie. Alcuni elementi comuni e specifici, comunque, consentono di identificare tre tipologie di ambienti, legati alle grotte del mesolitorale, ovvero la zona che dipende dal ritmo delle maree, alle grotte dove penetra seppure fiocamente la luce e alle grotte dove prevale il buio. Condizioni che risultano determinanti per la presenza di alcune specie animali tipiche del sostrato roccioso invece di altre. Animali, perché è la fauna che è ovunque prevalente, in quanto riesce ad adattarsi anche alle condizioni più estreme dei differenti microhabitat, mentre i vegetali, che dipendono dalla luce per la fotosintesi clorofilliana, non sono compatibili con tutte le grotte. E infatti anche i biocostruttori dentro le grotte sono rappresentati solo da animali, come il policheto sedentario Protula dal ciuffo rosso (Protula tubularia), che come gli altri policheti sedentari costruisce il tubo calcareo in cui vive. Proprio la saldatura tra tanti tubi forma nelle grotte delle spettacolari stalattiti, che possono arrivare a misurare anche qualche metro.
Nelle grotte del mesolitorale, che vengono sommerse in tutto o in parte a seconda del movimento delle maree, ,i vegetali sono presenti vicino agli ingressi o in punti dove arriva la luce e si tratta, inoltre, di alghe rosse incrostanti come la Phymatolithon lenormandii, che predilige zone d’ombra, la Hildebrandia rubra con grande capacità di adattamento e la Catenella coespitosa, diffusa nell’Adriatico e sulle coste occidentali italiane. La fauna, invece, è largamente rappresentata da poriferi, celenterati, briozoi, serpulidi e madreporari come la madrepora gialla Leptopsammia pruvoti e la madrepora Polycyathus muellerae. Poi i crostacei come il granchio Dromia personata, il gamberetto meccanico o alifantozza rosa (Stenopus spinosus), che vive fino a 500 metri di profondità e, quanto alle specie ittiche, la brotola nera (Grammonus ater), una specie notturna che vive fino ai 700 metri. Questa tipologia di grotte in Sardegna era un tempo frequentata dalla foca monaca (Monachus monachus).
Le grotte semioscure sono popolate da specie dai colori molto vivaci come la margherita di mare (Parazoanthus axinellae), il corallo rosso (Corallium rubrum), la madrepora gialla (Leptosammia pruvoti), la madrepora Phyllangia mouchezii, i cui polipi sono i più grandi del Mediterraneo, le madrepore che vivono in zone d’ombra Hoplangia durotrix e Caryophyllia inornata, oltre alle gorgonie. E vi si trovano idroidi, briozoi, ascidie come la Pyura duraarancione, cicale, aragoste, astici, gamberetti e, tra i pesci, cernia bruna, corvina, mostella bruna (Phycis phycis), gronco (Conger conger) e il ghiozzetto di Marsiglia (Gammogobius steinitzi).
Minore è la presenza e varietà di animali nelle grotte oscure, dove si sono adattate specie che solitamente vivono fuori dalle grotte a grandi profondità, dove filtra poca luce. Tra queste, il porifero Petrobiona massiliana, un fossile vivente che era stato ritenuto estinto, e poi policheti, serpulidi, foraminiferi, crostacei come il granchio delle grotte (Herbstia condyliata), la rossa lumaca di mare Homalopoma sanguineum e, tra i pesci, il pesce cardinale color arancio (Apogon imberbis), che vive nelle tane fino a 250 metri, e la brotola nera (Grammonus ater), presente anche a notevoli profondità.