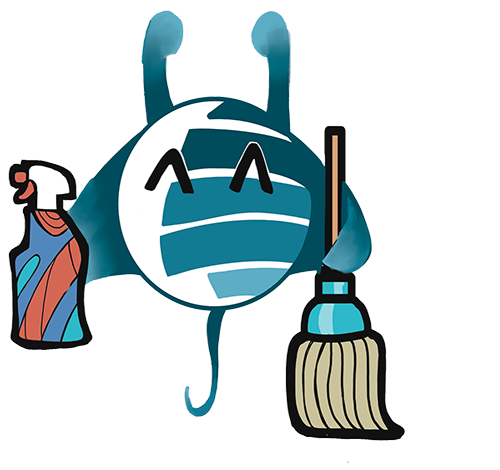Ci sono aspetti della vita dei capodogli del Mediterraneo che sono ancora da indagare e approfondire.
A fare luce su uno di questi è intervenuto lo studio, frutto del lavoro di diversi gruppi di ricerca di Università italiane coordinati fra loro, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica internazionale “Animals” nel 2023 con il titolo “Life History Traits of Sperm Whales Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 Stranded along Italian Coasts (Cetartiodactyla: Physeteridae)” ovvero “Tratti della storia della vita dei capodogli Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 spiaggiati lungo le coste italiane (Cetartiodactyla: Physeteridae)”.
Nell’articolo vengono presentati e analizzati nuovi dati, relativi al rapporto tra l’età dei grandi cetacei, la loro lunghezza e l’età della maturità sessuale, che sono stati raccolti studiando individui spiaggiati lungo le coste italiane. Ė emerso che i capodogli maschi mediterranei raggiungono la maturità sessuale all’età di dieci anni e che, rispetto ai loro simili che vivono in Atlantico, a parità di lunghezza dei loro corpi, presentano un’età più avanzata.  Ma la ricerca ha anche individuato tra gli esemplari esaminati una femmina mediterranea gravida, di età stimata tra i ventiquattro e i venticinque anni e lunga “appena” sei metri e mezzo, mentre è noto che le femmine della specie, che raggiungono la maturità sessuale a nove anni, a quell’età presentano una lunghezza di nove metri. Queste osservazioni sulla diversità di dimensioni tra i capodogli mediterranei e i loro stretti parenti atlantici hanno suggerito due ipotesi, fondate su elementi ecologici e genetici. La prima riguarda la possibilità che quella differenza sia collegata al minore apporto energetico a cui sarebbero esposti gli esemplari mediterranei, per fattori riguardanti la catena trofica e le minori dimensioni delle prede. La seconda ipotesi fa riferimento alla bassa diversità genetica, frutto degli accoppiamenti tra individui imparentati tra loro. Questa condizione in particolare suggerisce la necessità di azioni specifiche di conservazione per la popolazione di capodogli nel Mediterraneo, in quanto la loro capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali sarebbe inferiore a quella dei capodogli atlantici.
Ma la ricerca ha anche individuato tra gli esemplari esaminati una femmina mediterranea gravida, di età stimata tra i ventiquattro e i venticinque anni e lunga “appena” sei metri e mezzo, mentre è noto che le femmine della specie, che raggiungono la maturità sessuale a nove anni, a quell’età presentano una lunghezza di nove metri. Queste osservazioni sulla diversità di dimensioni tra i capodogli mediterranei e i loro stretti parenti atlantici hanno suggerito due ipotesi, fondate su elementi ecologici e genetici. La prima riguarda la possibilità che quella differenza sia collegata al minore apporto energetico a cui sarebbero esposti gli esemplari mediterranei, per fattori riguardanti la catena trofica e le minori dimensioni delle prede. La seconda ipotesi fa riferimento alla bassa diversità genetica, frutto degli accoppiamenti tra individui imparentati tra loro. Questa condizione in particolare suggerisce la necessità di azioni specifiche di conservazione per la popolazione di capodogli nel Mediterraneo, in quanto la loro capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali sarebbe inferiore a quella dei capodogli atlantici.
Lo studio è partito da una descrizione delle caratteristiche e dei comportamenti del capodoglio, Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758, che è tra i mammiferi marini più diffusi a livello mondiale, dai mari tropicali ai polari. Anche nel Mediterraneo è largamente presente, ma più nella parte occidentale del bacino che in quella orientale e, in Italia, è più frequente nel Tirreno e soprattutto nel Mar Ligure e nello Ionio, non altrettanto in Adriatico. Ė il più grande dei cetacei odontoceti, tanto che può raggiungere i ventuno metri di lunghezza. Raggiunge la maturità sessuale tra i dieci e i tredici anni, ma l’età può scendere in via eccezionale ai sette anni delle femmine e salire ai diciotto/ventuno dei maschi. I capodogli possono vivere fino a ottant’anni. Le femmine partoriscono dopo 14/16 mesi di gestazione un solo cucciolo ogni quattro/cinque anni, per cui ogni femmina arriva a dare alla luce solo quattro/cinque figli durante la vita. I piccoli usufruiscono di cure parentali per periodi lunghi e l’allattamento. che dura solitamente un paio d’anni, può prolungarsi fino ai cinque.
La conoscenza di questi animali è frutto prevalentemente di studi effettuati su esemplari che vivono negli oceani, al contrario diversi aspetti della vita dei capodogli mediterranei sono stati scarsamente approfonditi e pochi erano stati gli studi dedicati in particolare al tasso di crescita corporea e all’età della maturità sessuale precedentemente alla ricerca pubblicata. Che evidenzia come la popolazione di capodogli del Mediterraneo si caratterizzi per una variabilità genetica molto più bassa rispetto ai loro parenti atlantici, da ascriversi all’espansione recente della popolazione e alle modalità della sua formazione circa 20mila anni fa. Questi aspetti ancora oscuri possono essere oggetto di studio utilizzando gli animali morti e spiaggiati lungo le coste della Penisola e delle isole come avvenuto in questo caso.
Per approfondire aspetti diversi della vita dei capodogli e le loro possibili correlazioni si è scelto un approccio multidisciplinare, attraverso analisi molecolari, morfologiche e statistiche sui campioni di tessuti e sui denti di cetacei spiaggiati in Italia. Le finalità della ricerca sono state identificate nell’ individuazione dell’origine geografica dei singoli esemplari per mezzo del DNA mitocondriale; nella stima dell’età degli individui contando i gruppi di strati di crescita dei denti: nell’analisi del rapporto tra età e lunghezza; nella stima dell’età della maturità sessuale, confrontata con l’età individuale già valutata attraverso l’analisi dei denti e dello stato riproduttivo.
Le analisi e gli approfondimenti che ne sono scaturiti, hanno consentito di raggiungere l’obiettivo della ricerca di incrementare la conoscenza della biologia dei capodogli mediterranei. Più specificamente, è stata evidenziata l’esistenza di una correlazione positiva tra la durata della vita e la lunghezza del corpo dei maschi adulti sia del Mediterraneo che dell’Atlantico settentrionale. Per i maschi, la maturità sessuale si raggiunge a dieci anni e a parità di lunghezza, i maschi mediterranei sono più vecchi di quelli dell’Atlantico. La femmina gravida a un’età stimata tra i 24 e i 26 anni, ma lunga solo sei metri e mezzo, risulta essere la più piccola femmina gravida della specie che si conosca. Lo studio ha dimostrato che le minori dimensioni dei capodogli mediterranei sono una conseguenza della consanguineità che è emersa nella popolazione e dell’adattamento a un ambiente che offre prede più piccole e una disponibilità inferiore di nutrienti. Per effetto di questi fattori e, in particolare, della loro bassa diversità genetica, i capodogli del Mediterraneo probabilmente hanno una minore capacità di rispondere ai cambiamenti ambientali in corso rispetto ai loro simili di altri mari, per cui, a fini della loro tutela e conservazione, è necessario tenerne monitorata la popolazione.
Gli Autori dello studio
Nicola Maio, Tatiana Fioravanti, Lucrezia Latini, Agnese Petraccioli, Marcello Mezzasalma, Bruno Cozzi, Sandro Mazzariol, Michela Podestà, Gianni Insacco, Francesco Pollaro, Giuseppe Lucifora, Ida Ferrandino, Nicola Zizzo, Filippo Spadola, Fulvio Garibaldi, Fabio Maria Guarino, Andrea Splendiani, Vincenzo Caputo Barucchi.
I centri di ricerca che hanno contribuito:
Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II; Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Università Politecnica delle Marche; Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, Università della Calabria; Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, Università degli Studi di Padova; Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Sezione di Zoologia dei Vertebrati; Museo Civico di Storia Naturale di Comiso; Centro Studi Ecosistemi Mediterranei; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Museo della Fauna, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina.