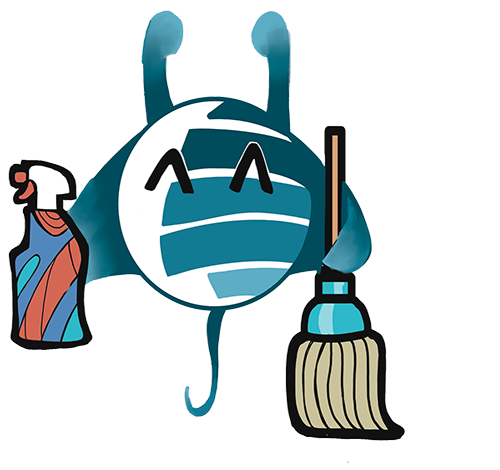Dall’abbandono del corpo alla trascendenza dell’esperienza
Nell’inspirazione c’è il prendere, il trattenere, l’afferrare la vita.
Nell’espirazione il lasciare andare. Banale e potente. Quando l’aria esce lentamente dai polmoni, qualcosa in noi si distende: i muscoli si ammorbidiscono, il battito rallenta, la mente smette di aggrapparsi e la resistenza si dissolve.
Di fronte al dolore, l’istinto è irrigidirsi. Il corpo si contrae, la mente protesta, cerca una via di fuga. Un soffio lungo e consapevole rovescia questo meccanismo: non combatte i patimenti, li accoglie. Non li nega, non li elimina: rinuncia ad opporvisi.
Nel “mollare il respiro” avviene qualcosa di incredibile: la sofferenza resta, eppure perde il suo sapore ed il suo potere. Diventa un fenomeno che attraversa il corpo, non più un nemico che lo assedia.
Lo stesso accade nel contatto con il freddo estremo. L’acqua gelida è un’esperienza radicale, che richiama immediatamente alla sopravvivenza. Ogni fibra chiede di uscire, di scappare.
Espirando lentamente e a lungo, si scopre una possibilità inattesa: stare.
Stare nel ghiaccio, stare nel disagio, stare nel limite. Il freddo continua a esistere, ma non occupa più tutto lo spazio dell’essere.
L’emissione crea una distanza sottile, una fessura di consapevolezza in cui è possibile osservare senza essere travolti.
In questa indagine nasce una scissione delicata: il corpo è immerso nell’acqua pungente, ma “io” non coincido più del tutto con esso. Come se una parte di me, sospinta fuori dall’esalazione, si fosse posta appena oltre i confini della carne. Non è dissociazione nel senso di fuga, piuttosto un ampliamento: la materia continua la sua pratica, mentre la coscienza la contempla. Il freddo non sparisce, ma non è più “mio” nello stesso modo.
E’ forse questa la morte?
L’ultimo respiro, dopotutto, è una lunga espirazione.
Non un prendo, ma un lascio. Non un atto di volontà, ma un ritirarmi.