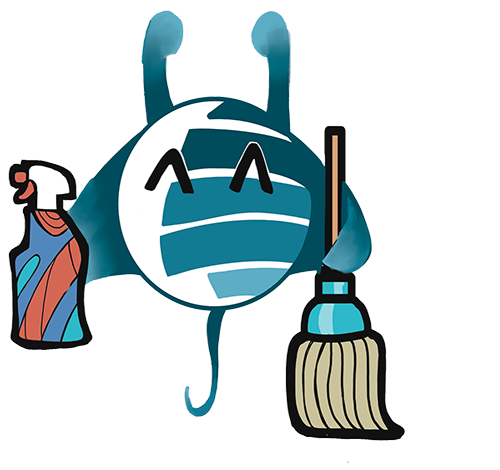Per decenni la foca monaca (Monachus monachus) è stata praticamente un fantasma, protagonista di qualche avvistamento in mare aperto tanto raro da meritare annunci ufficiali e titoli di giornale in grande evidenza.
E ancora oggi gli incontri sono talmente sporadici da diventare una preziosa informazione di natura scientifica per i gruppi di ricerca che si dedicano al suo studio. Infatti, il pinnipede, un tempo diffusissimo in Italia e nel resto del bacino mediterraneo, soprattutto nell’ultimo cinquantennio ha subito un decremento demografico talmente drastico da essere considerato una delle cento specie di mammiferi a più alto rischio di estinzione sul pianeta.
Erano gli anni ’70 del secolo scorso quando, contestualmente all’allarme per la riduzione degli esemplari in tutti i siti di loro precedente, stabile frequentazione, gli esperti ne anticiparono l’estinzione entro l’arrivo del nuovo millennio. Previsione smentita fortunatamente dagli avvistamenti che si sono verificati dopo quella data fatidica e che, nel tempo, pur essendo sempre in numero molto limitato, hanno evidenziato un trend in crescita, lasciando immaginare che il mammifero marino sia in faticosa, lenta ripresa. Dovuta senza alcun dubbio alle misure di tutela e di conservazione adottate nel tempo a suo favore, ma anche alla capacità di resilienza dell’animale, a cui non è estranea la sua notoria diffidenza nei confronti dell’uomo. Frutto della caccia di cui la foca è stata vittima nei secoli per la carne, la pelliccia e il grasso, che veniva utilizzato come olio, ma anche perché considerata una pericolosa “ladra” dai pescatori, in quanto le si attribuiva la distruzione delle reti per prenderne i pesci.
Unico pinnipede del Mediterraneo, la foca monaca deve sia il suo nome scientifico sia quello con cui è comunemente nota al colore del suo mantello, che ricorda il saio di un monaco. Negli adulti il pelo corto è più scuro nel maschio, con possibili striature e una grossa macchia chiara sul ventre (che nei maschi arriva fino al bianco), mentre i piccoli nascono neri con una macchia bianca in corrispondenza dell’ombelico. Il corpo cilindrico, più piccolo nelle femmine, può arrivare a una lunghezza di circa due metri e mezzo, per un peso che raggiunge i quattrocento chili. La testa è rotonda con grandi occhi e due folti ciuffi di vibrisse ai lati del labbro superiore. L’animale è dotato di due pinne pettorali dotate di unghie e di due pinne posteriori. A queste è affidato il movimento natatorio, mentre le pinne pettorali servono per la direzione.
Tra le caratteristiche della foca monaca vi è quella di essere un’ottima nuotatrice, in grado di trascorrere gran parte della vita in mare aperto, di coprire ogni giorno anche distanze notevoli di qualche decina di chilometri e di raggiungere profondità importanti in apnea, forse anche i duecento metri, sebbene la profondità massima accertata è di 90. La pesca viene effettuata con immersioni frequenti e a tratti continue, emergendo giusto per respirare. Molto meno agile è il movimento fuori dall’acqua, giacchè non è in grado di alzarsi sulle pinne posteriori come altre specie di foche, ma procede ventre a terra. Anche per dormire, dunque, resta in mare aperto, in superficie o anche in anfratti sommersi da cui risale per respirare.
La monaca ha un ciclo vitale tra i venti e i trent’anni e diventa fertile intorno ai quattro anni, quando si accoppia per la prima volta. La stagione riproduttiva comprende estate e autunno e partorisce un piccolo all’anno, dopo undici mesi di gestazione. Il cucciolo, lungo circa 80 centimetri e dal peso tra i 16 e i 18 chili, viene dato alla luce in grotte riparate o in tratti di costa sabbiosa prossimi al mare, prevalentemente nei mesi di settembre e ottobre. Vi resta per tutto il periodo dell’allattamento, che dura tra le 11 e le 17 settimane. La madre resta vicino al figlio solo nelle prime settimane di vita, poi si allontana per la pesca e torna dal piccolo solo per allattarlo. Sebbene entri in acqua abbastanza presto, il cucciolo inizia a nuotare dopo lo svezzamento, intorno ai quattro mesi di vita. Tutte caratteristiche che in quella fase lo rendono particolarmente vulnerabile e infatti la mortalità dei cuccioli, che è altissima, ha rappresentato uno degli elementi sfavorevoli e dei motivi di regresso della specie. I giovani che sopravvivono, si allontanano dal gruppo di appartenenza a cui non si ricongiungeranno. I maschi, dal canto loro, sono molto territoriali e i combattimenti sono piuttosto frequenti.
L’animale, che caccia di giorno e di notte, si nutre di pesci, sia ossei che cartilaginei, di crostacei e di cefalopodi, in particolare di polpi, che sono una delle sue prede preferite.
Avvistamenti e conservazione
Quando era ancora molto diffusa, la foca monaca era presente in tutti i mari intorno alla Penisola e alle isole. L’animale marino sacro ad Apollo e prediletto da Posidone, secondo la mitologia greca, era di casa in varie parti della Sardegna, in particolare nel golfo di Orosei, dove numerose grotte ne accoglievano esemplari in procinto di partorire o impegnate nell’allevamento dei piccoli nei primi mesi di vita. Proprio in quell’area fu documentata l’ultima nascita nel mare italiano nel 1986. Altra zona di riproduzione molto frequentata era l’Arcipelago Toscano, poi alcune isole minori della Sicilia e, risalendo l’Adriatico, le isole Tremiti fino all’Istria, alla Croazia e alla Dalmazia. E il primo grido dall’allarme sul futuro della foca fu lanciato proprio in Dalmazia, dove già nel 1935 fu emanato il primo decreto di tutela di una specie a rischio di estinzione.
Sono pressappoco gli stessi siti dove, negli anni bui della diminuzione drastica delle popolazioni, si sono verificati sporadici avvistamenti, che hanno tenuto viva la speranza della sopravvivenza del pinnipede mediterraneo. Di cui si contano ormai poche centinaia di esemplari, in piccoli gruppi rilevati nel Mediterraneo orientale tra Grecia e Turchia fino al Mar Rosso e, nel Mediterraneo occidentale, nel mare del nord-Africa e lungo la costa africana in Atlantico.
Vittima della caccia a cui è stata sottoposta, della perdita di habitat (soprattutto per l’allevamento dei cuccioli) legata allo sviluppo turistico anche in zone solitamente selvagge, delle catture accidentali con le reti da pesca e di inquinamento e diffusione della plastica nel mare, la foca monaca è diventata una specie protetta, oggetto di progetti e attività di conservazione specifici. Tra questi, le azioni poste in essere dal Wwf con il Gruppo Foca Monaca fin dal 1976, per monitorare la presenza dell’animale nelle grotte e nei luoghi protetti dove soleva sostare per la riproduzione o anche solo di passaggio prima della crisi. Grazie all’impegno di volontari e di esperti, è stato così possibile documentare con telecamere le visite, comunque molto rare, delle foche nelle grotte marine in varie parti d’Italia. Prezioso per riuscire a rilevare il passaggio e la presenza degli animali si è rivelato, inoltre, lo studio del DNA ambientale. I volontari raccolgono campioni di acqua di mare, che vengono filtrati con particolari kit e l’Università di Milano Bicocca fa le analisi. Grazie a questo tipo di approfondimento sono state evidenziate delle aree di presenza in Istria e laguna veneta; Salento e golfo di Taranto; le isole minori siciliane; Sardegna orientale e canyon di Caprera; Arcipelago Toscano e Baleari.
Sia queste tracce che gli avvistamenti più frequenti hanno rivelato che la foca monaca in questi decenni, tenendosi lontana dall’uomo, non è scomparsa definitivamente, ma ha iniziato a invertire la rotta, anche per effetto dell’istituzione delle Aree Marine Protette che tutelano alcuni dei suoi siti prediletti. Così, nel 2015 il livello di vulnerabilità delle foche mediterranee, che sono un animale superprotetto a livello nazionale dal 1992, è stato ufficialmente rivisto dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura IUCN da specie in pericolo critico e specie in pericolo.