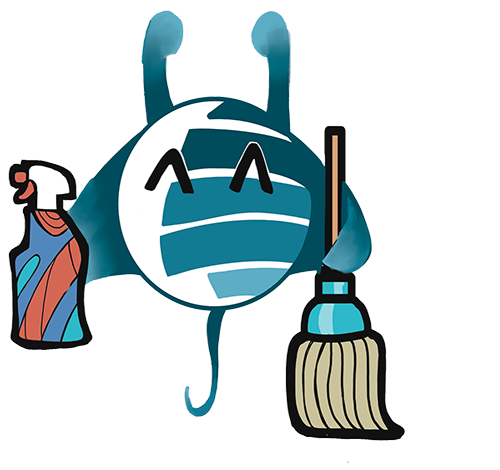L’elemento che più lo distingue anche all’occhio meno esperto, tanto da entrare nel suo nome comune, è un ciuffo di penne ricurve sul capo che fa parte della livrea nuziale del maschio.
Ė il marangone dal ciuffo, il cui nome scientifico è Gulosus aristoteles, ma che è anche identificato come Phalacrocorax aristoteles, a sottolineare l’appartenenza alla famiglia Phalacrocoracidae a cui appartengono anche i cormorani, di cui infatti è uno stretto parente. E la forma del corpo lo testimonia, sebbene il marangone sia più piccolo con i suoi 65/80 centimetri di lunghezza, il lungo collo più slanciato e il capo più arrotondato. Condividono anche la colorazione scura: il marangone adulto ha un piumaggio nero con riflessi verde scuro sul corpo e rosso purpureo sulle ali e scure sono anche le zampe palmate; i giovani hanno il ventre più chiaro tendente al biancastro.
Ė un uccello pelagico, presente dall’Oceano Atlantico al bacino mediterraneo. Proprio tra il Mediterraneo e il Mar Nero vive la sottospecie Phalacrocorax aristoteles desmarestii, che in Italia è diffusa soprattutto in Sardegna e in misura molto minore nell’Arcipelago Toscano e nelle Isole Pontine, oltre a qualche coppia segnalata anche alle Isole Pelagie. Infatti, il marangone popola isole e tratti costieri non urbanizzati di golfi e baie e nidifica su isolotti e perfino scogli affioranti, utilizzando cavità e fratture nelle rocce, in luoghi riparati e al sicuro dalle prede terrestri.
La stagione della riproduzione, per la quale il maschio sfoggia il ciuffo, inizia a dicembre e prosegue fino a marzo. La femmina depone in media tre uova, che vengono covate dalla coppia per circa un mese. Dopo la schiusa, i pulcini restano nel nido per un paio di mesi, prima di iniziare a volare.
Finita quella fase, i marangoni si riuniscono in grandi stormi e insieme vanno alla ricerca di siti migliori in cui approvvigionarsi di cibo. Ma non sono, comunque, migratori su lunghe distanze, anzi sono decisamente stanziali per quanto riguarda la nidificazione e non solo. Dotati di un’apertura alare che raggiunge il metro, i marangoni dedicano questa caratteristica a procurarsi il cibo, per cui sono abilissimi pescatori, che vanno alla ricerca delle loro prede fin dentro il mare, rincorrendo i pesci sott’acqua.
Sebbene non siano ad alto rischio, i marangoni sono una presenza rara, che lo è diventata ancora di più anche in Italia. Le popolazioni, infatti, continuano a regredire un po’ dovunque, a cominciare dal golfo di Trieste e dall’Adriatico. Negli ultimi cinquant’anni il numero delle coppie censite lungo le coste della Sardegna è diminuito di oltre il cinquanta per cento. Poche coppie restano nell’Arcipelago Toscano e negli altri siti di riferimento in Italia.
Una condizione critica legata tutta alle attività umane, perché gli uccelli soffrono l’inquinamento marino, in particolare da metalli pesanti. Nemici sono anche reti di pesca e ami di palamiti, l’urbanizzazione dei siti di riproduzione e l’”invasione” del loro mare dai turisti. A tutela della specie c’è innanzitutto la Direttiva Uccelli dell’Unione europea, ma i marangoni sono inseriti sia nella Convenzione di Berna che di Barcellona.