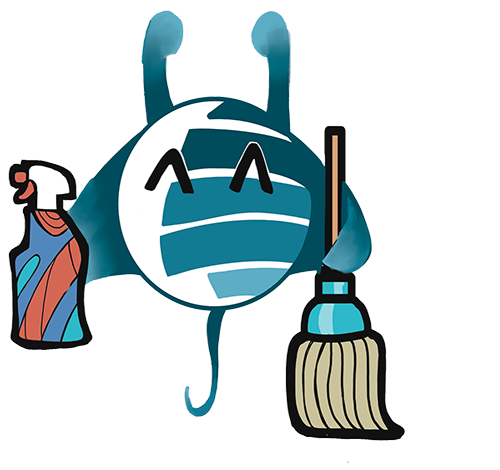Se non fosse sempre in movimento, mentre esplora la battigia con il lungo becco alla ricerca di cibo, la livrea e le dimensioni renderebbero impossibile distinguerlo nella distesa di sabbia.
Ė tutta lì, sulla spiaggia, la vita del fratino (Charadrius alexandrinus), da quando esce dall’uovo e, dopo appena un paio d’ore, anche dal nido, per lanciarsi già autonomo alla scoperta dell’ambiente prossimo al mare che dovrebbe garantirgli tutto ciò di cui ha bisogno per nutrirsi e riprodursi. Dovrebbe, perché il piccolo trampoliere, abitante dei litorali sabbiosi, trova condizioni sempre meno favorevoli alla sua sopravvivenza sia in Italia che nel resto d’Europa, dalla Scandinavia al Mediterraneo, tanto da essere stato inserito da qualche anno nella lista delle specie in pericolo di estinzione.
Piccolo, con un’altezza di una quindicina di centimetri e un peso che non raggiunge l’etto, il fratino prende il nome dalla fascia nera che circonda il capo del maschio e che fa pensare al cappuccio di un frate. Ė quello l’elemento più vistoso della livrea insieme a un’altra striscia nera che dal becco arriva agli occhi e alla macchia nera sulla fronte. Poi, la parte superiore del corpicino è di un color grigio-bruno che d’inverno diventa più rossastro, mentre la parte inferiore e il collo sono bianchi, con le esili zampe grigio-nerastre. Una colorazione che, con le piccole variazioni stagionali, è perfetta per confondersi con la sabbia. Ancora meno vistoso è il piumaggio delle femmine, prive delle strisce nere, con una prevalenza di tonalità grigie anche sul capo e sul collo e con le zampe marroncine.
Sono tra gli uccelli più piccoli presenti in Italia, fino a qualche decennio fa molto diffusi nei pressi di laghi salati e in alcune zone umide più interne, come nella Pianura padana. Vicini alle zone dunali, ma non chiusi in esse, in particolare nei punti coperti da vegetazione. Il fratino si muove sulla sabbia, dove trova le sue piccole prede, molluschi e anellidi, quando la marea si ritira, oltre a scavare nella sabbia con il becco o saltando curiosamente per far emergere formiche e altri piccoli insetti nascosti.
Nonostante le piccole dimensioni, è un migratore che può coprire anche grandi distanze e volare per tanti chilometri per raggiungere il nord Africa in autunno e tornare in Europa a primavera. Ma non tutti migrano, in tanti sono stanziali e si fermano dove nidificano. La stagione degli amori comincia a marzo e le coppie fanno il nido proprio all’inizio della primavera. I nidi sono delle buchette scavate nella sabbia, in punti rialzati dove la spiaggia è asciutta e la vegetazione è scarsa. Vi vengono deposte fino a tre uova, di circa tre centimetri di diametro, di un colore beige simile alla sabbia e picchiettate di nero. Dopo una cova tra i 24 e i 28 giorni, in cui maschio e femmina si alternano, escono i pulcini, che sono nidifughi. E infatti lasciano quasi subito il nido e, sotto il controllo dei genitori per la prima settimana di vita, sono in grado di procurarsi il cibo da soli fin dal primo giorno. Se ritengono di essere in pericolo, i pulcini si stendono immobili, fingendo di essere morti.
Una specie in continuo regresso
Nonostante le ardite soluzioni difensive che adottano, i fratini sono notevolmente e progressivamente diminuiti negli ultimi decenni. Un fenomeno riscontrato in ogni parte d’Europa in cui sono presenti e l’Italia non fa eccezione, anzi. Tutte le aree costiere in cui erano un tempo molto numerosi, l’Adriatico settentrionale e meridionale, il Tirreno, la Sicilia e soprattutto la Sardegna hanno fatto registrare un regresso significativo pari a circa la metà degli esemplari. Un trend che si è mantenuto costante da un anno all’altro. Nel complesso, ne restano circa 37 colonie e meno di 2000 coppie, mentre nei Paesi dell’Unione Europea sono circa 11mila.
Davanti a questi dati, l’Ue ha inserito il fratino nella Convenzione di Berna, che tutela la flora e la fauna, nella Convenzione di Bonn, dedicata alla fauna migratrice, e nella Direttiva Uccelli, indicandovela come specie particolarmente protetta. Altre misure sono state adottate dagli Stati per cercare di incidere anche sulle cause note del fenomeno: in primo luogo, la perdita degli habitat costieri dove il fratino vive, sacrificati all’espansione del turismo balneare e, in generale, all’antropizzazione spinta della fascia costiera un po’ dovunque. La frequentazione umana delle spiagge e delle zone dunali anche fuori stagione moltiplica i rischi per la sopravvivenza dei singoli esemplari, che spesso sono preda di cani lasciati incustoditi e di gatti randagi, e dei nidi, che essendo mimetizzati nella sabbia, finiscono con l’essere calpestati da chi passeggia o distrutti durante la pulizia meccanica delle spiagge.
Così, soprattutto nelle zone costiere tutelate da Parchi nazionali, Riserve regionali e Aree marine protette sono state introdotte regole precise a cui debbono attenersi i frequentatori di spiagge, dune, pinete e sentieri prossimi ai siti in cui vive il fratino. E in alcune zone sono stati avviati interventi di specifica protezione e ricostruzione dell’habitat costiero, che hanno cominciato a dare qualche risultato nel contrasto alla riduzione delle colonie. Ė stato anche istituito un Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino, che tiene monitorato il numero di coppie in riproduzione e la consistenza della popolazione in Italia.
Considerati i rischi a cui è esposto, la presenza del fratino rappresenta un importante indicatore della salute dell’ambiente marino. Perciò, dal futuro del piccolo trampoliere dipende anche la salvaguardia della fascia costiera e dei suoi preziosi habitat naturali.