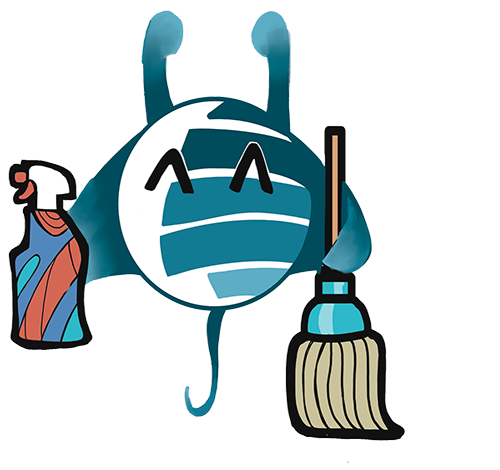Una grande opera destinata a rivoluzionare la navigazione, il commercio internazionale e l’economia mondiale.
Tutto questo era ben presente a chi, investendovi notevoli risorse, aveva voluto realizzare il canale di Suez, inaugurato nel 1869. Non altrettanta attenzione e valutazione erano state probabilmente riservate ai cambiamenti ambientali che quell’intervento avrebbe potuto comportare nel breve e, più ancora, nel lungo periodo. Di sicuro, Ferdinand Marie de Lesseps, al vertice della compagnia francese che aveva realizzato il canale di collegamento tra il Mar Rosso e il Mediterraneo, non avrebbe mai immaginato che tanti decenni dopo, nel 2010, dal suo cognome sarebbe derivato un aggettivo, “lessepsiano”, coniato dal grande zoologo romeno Francis Dov Por. Un aggettivo che da allora viene utilizzato per definire tutti gli organismi, perlopiù animali, ma anche vegetali, che dall’ambiente tropicale del Mar Rosso e anche degli Oceani Indiano e Pacifico, si sono spostati nel Mare Nostrum e vi si sono stabilmente insediati.  Che poi sono la stragrande maggioranza degli organismi cosiddetti “alieni”, giacchè il numero delle specie giunte dall’Atlantico attraverso lo Stretto di Gibilterra è di gran lunga inferiore. Peraltro, sono definiti “antilessepsiani” animali e vegetali che hanno seguito il percorso inverso dal Mediterraneo al Mar Rosso, ma in numero piuttosto ridotto.
Che poi sono la stragrande maggioranza degli organismi cosiddetti “alieni”, giacchè il numero delle specie giunte dall’Atlantico attraverso lo Stretto di Gibilterra è di gran lunga inferiore. Peraltro, sono definiti “antilessepsiani” animali e vegetali che hanno seguito il percorso inverso dal Mediterraneo al Mar Rosso, ma in numero piuttosto ridotto.
 I primi alieni erano stati introdotti passivamente nel nuovo areale mediterraneo con l’acqua di sentina delle navi o attaccati alle chiglie. Solo in seguito è iniziata la migrazione vera e propria, favorita nel tempo da alcuni cambiamenti legati agli effetti sul lungo periodo dell’impatto ambientale del canale e delle opere collegate. All’inizio, infatti, lo spostamento delle specie dal Mar Rosso era bloccato sia dalle diverse temperature del Mediterraneo che dall’altissima salinità dei Laghi amari, parte integrante del canale. In quei laghi, le specie che vi capitavano, non sopravvivevano. Si trattava, dunque, di una barriera naturale estremamente efficace. Ma poi il collegamento esterno ha determinato l’immissione in quei bacini di acqua dolce, che ha progressivamente ridotto della metà la salinità iniziale, facendo dei Laghi amari un collegamento praticabile anche per le specie autoctone del Mar Rosso, oltre che per le navi. La realizzazione della seconda diga di Assuan nel 1971 e il restyling con ampliamento del canale nel 2015 hanno creato altre condizioni propizie alla migrazione.
I primi alieni erano stati introdotti passivamente nel nuovo areale mediterraneo con l’acqua di sentina delle navi o attaccati alle chiglie. Solo in seguito è iniziata la migrazione vera e propria, favorita nel tempo da alcuni cambiamenti legati agli effetti sul lungo periodo dell’impatto ambientale del canale e delle opere collegate. All’inizio, infatti, lo spostamento delle specie dal Mar Rosso era bloccato sia dalle diverse temperature del Mediterraneo che dall’altissima salinità dei Laghi amari, parte integrante del canale. In quei laghi, le specie che vi capitavano, non sopravvivevano. Si trattava, dunque, di una barriera naturale estremamente efficace. Ma poi il collegamento esterno ha determinato l’immissione in quei bacini di acqua dolce, che ha progressivamente ridotto della metà la salinità iniziale, facendo dei Laghi amari un collegamento praticabile anche per le specie autoctone del Mar Rosso, oltre che per le navi. La realizzazione della seconda diga di Assuan nel 1971 e il restyling con ampliamento del canale nel 2015 hanno creato altre condizioni propizie alla migrazione.
Tra la fine dell’Ottocento e la fine del Novecento si era osservato che la maggior parte delle specie aliene, tutte di origine tropicale, una volta entrate nel Mediterraneo, restavano nella sua parte più meridionale e orientale, trovandovi habitat più compatibili con quelli di provenienza. L’innalzamento della temperatura del mare che ha subito una accelerazione nell’ultimo trentennio, con un aumento di circa un grado, ha reso possibile un’espansione verso occidente. E si è aggiunta, inoltre, quella verso nord che sta interessando anche le specie autoctone. 
Esemplare la storia dell’Halophila stipulacea, la pianta marina tropicale che fu avvistata per prima nel Mediterraneo già nel 1894. Da allora, per lungo tempo era rimasta nella parte orientale del bacino, prima di iniziare a diffondersi a occidente, fino a comparire nel Tirreno, dove ha raggiunto la Francia, e nell’Adriatico. Uno studio dell’Università del Salento, pubblicato nel 2023 sulla rivista scientifica “Mediterranean Marine Science”, ha rivelato che la pianta ha formato ampie praterie al largo della costa salentina, tanto che i ricercatori hanno lanciato un appello per coadiuvare le attività di monitoraggio necessarie a verificare le trasformazioni nell’ambiente marino indotte da una presenza così massiccia dell’aliena.
Lo stesso fenomeno ha riguardato, anzi sta ancora riguardando, molte delle specie animali provenienti dall’Oceano Indiano e dal Mar Rosso. Tra le tante, il pesce coniglio scuro (Siganus luridus), che è molto diffuso nel Mediterraneo orientale, dove è stato già sperimentato il suo forte impatto ambientale, perché, da erbivoro che si nutre di alghe brune, ha creato parecchi danni lì dove la sua presenza è massiccia. In Italia è stato avvistato nel 2003 per la prima volta e da allora, seppure sporadici, si sono susseguiti altri avvistamenti. Altrettanto dicasi per il pesce coniglio striato (Siganus rivulatus), comparso nei mari italiani per la prima volta nel 2015.