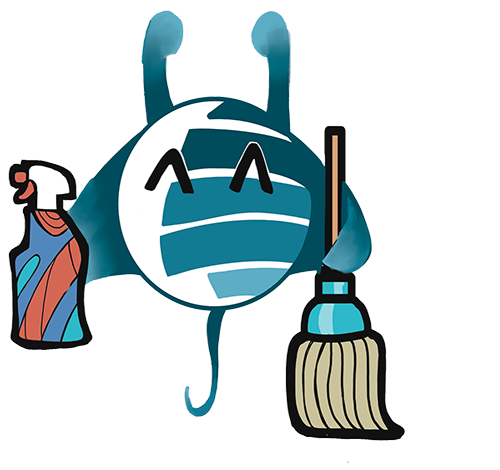Il volo è lungo e impegnativo, la ricerca spasmodica. Ogni giorno, quando il colore della notte lascia spazio al primo chiarore dell’alba, fino al calar del sole che inonda d’oro la superfice del mare.
Si spostano per decine, anche centinaia di miglia, per trovare banchi di piccoli pesci o comunque cibo sufficiente a soddisfare la fame vorace dei piccoli che aspettano, sempre da soli, negli anfratti tra le rocce dove sono deposti i nidi protettivi. Per una parte della primavera e tutta l’estate è questa la missione quotidiana che l’istinto impone alle berte per garantire il futuro della specie. Le piccole procellarie dispiegano tutta la loro abilità nel volo sulle rotte del Mediterraneo, dove trascorrono l’intero periodo della riproduzione, prima di ripartire, solitarie, per il lungo viaggio invernale sull’Oceano Atlantico. Comportamenti comuni, con qualche differenza, a due specie diverse, berta maggiore e berta minore, della stessa famiglia delle Procellaridae, entrambe frequentatrici delle coste italiane.
La Berta maggiore (Calonectris diomedea)
Ė lunga una cinquantina di centimetri per 600 grammi di peso, dotata di una coda corta e tondeggiante, di ali strette e di un’apertura alare che raggiunge il metro. Sul capo, il piumaggio è grigio chiaro, mentre sul dorso è bruno, bianchi collo e ventre, con becco giallo e zampe rosate. Il corpo che serve alla più grande berta europea per spostarsi, anche per mesi, sulle distese oceaniche senza mai toccare terra, volando per ore a una velocità che può raggiungere i 50 chilometri orari.
 Dall’autunno e per tutto l’inverno gli uccelli spaziano in Atlantico, da nord a sud, spingendosi alla ricerca di cibo fin sulle coste dell’Africa Australe e dell’America Meridionale. Poi, a marzo, il ritorno alla vita delle colonie, che si ritrovano sempre negli stessi siti, per iniziare una nuova stagione di riproduzione nel clima caldo del bacino mediterraneo, preferibilmente su isole e isolotti lontani dalla terraferma o sui tratti costieri meno antropizzati da un versante all’altro del Mare Nostrum. Con il raggrupparsi delle colonie, che contano anche migliaia di individui, si ritrovano le coppie, che restano fedeli nel tempo, o se ne costituiscono di nuove tra i giovani, che si riproducono a partire dal quinto anno di vita. Ha inizio così la fase degli amori e della costruzione dei nidi, ricavati perlopiù nelle fessure delle pareti di roccia sul mare, al riparo dalla luce e dagli elementi.
Dall’autunno e per tutto l’inverno gli uccelli spaziano in Atlantico, da nord a sud, spingendosi alla ricerca di cibo fin sulle coste dell’Africa Australe e dell’America Meridionale. Poi, a marzo, il ritorno alla vita delle colonie, che si ritrovano sempre negli stessi siti, per iniziare una nuova stagione di riproduzione nel clima caldo del bacino mediterraneo, preferibilmente su isole e isolotti lontani dalla terraferma o sui tratti costieri meno antropizzati da un versante all’altro del Mare Nostrum. Con il raggrupparsi delle colonie, che contano anche migliaia di individui, si ritrovano le coppie, che restano fedeli nel tempo, o se ne costituiscono di nuove tra i giovani, che si riproducono a partire dal quinto anno di vita. Ha inizio così la fase degli amori e della costruzione dei nidi, ricavati perlopiù nelle fessure delle pareti di roccia sul mare, al riparo dalla luce e dagli elementi.
Ad aprile, le femmine depongono un uovo a coppia, che coveranno con i maschi, facendo i turni per i lunghi viaggi diurni in cerca di cibo. La cova dura un paio di mesi, poi a fine giugno-luglio avviene la schiusa e inizia la fase di allevamento dei pulcini, nidicoli, dal piumaggio grigio con sfumature bluastre, che vengono assistiti dalla presenza dei genitori soltanto di notte, quando o il maschio o la femmina li raggiungono per nutrirli, rigurgitando quanto raccolto in mare con complessi rituali, che solo in parte sono stati ricostruiti dai ricercatori.
Il tempo della permanenza nel nido con il pulcino dura soltanto quando il cielo è buio, perché, ancor prima che faccia giorno, l’adulto riprende il mare a caccia di pesci, crostacei e cefalopodi. La pesca avviene in gruppo. L’uccello si tuffa verso la preda, una volta individuata, da una decina di metri di distanza e la cattura in superficie oppure la insegue sott’acqua.
Nel mese di ottobre, i pulcini iniziano a volare e lasciano il nido, in tempo per la migrazione autunnale, che divide le coppie e disgrega le colonie, fino all’inizio di primavera.
Tra i siti in cui la berta maggiore nidifica, numerosi sono in Italia, come Capraia, Pianosa nell’Arcipelago Toscano e le Tremiti. Tra tutti, il più importante dell’intero Mediterraneo è l’isola di Linosa, nell’arcipelago siciliano delle Pelagie, il cui mare è protetto da un’Area Marina Protetta. Le pareti rocciose dell’isola accolgono ogni anno per la nidificazione circa diecimila coppie. Che dopo la nascita dei pulcini, ogni giorno, si levano in volo arrivando spesso fino alle coste della Tunisia per rifornirsi.
La Berta minore mediterranea (Puffinus yelkouan)
Sebbene appartenga a un genere diverso (Puffinus), la Berta minore mediterranea, un tempo considerata sottospecie della Berta atlantica (Puffinus puffinus) e oggi riconosciuta specie endemica del Mediterraneo, presenta molte caratteristiche e abitudini simili alla Berta maggiore, certamente più grande per dimensioni. La minore, infatti, è lunga appena 30/35 centimetri e ha un’apertura alare inferiore al metro, tra i 70 e gli 84 centimetri. Più scura sul dorso e biancastra sul ventre, mostra zampe sporgenti rispetto alla coda quando è in volo. Una condizione in cui trascorre gran parte della sua vita, in mare aperto, alla ricerca di cibo per sé e per la prole. Per catturare le prede, perlopiù piccoli pesci, si tuffa fino a grandi profondità, ma non disdegna di recuperare i resti di cui si liberano i pescherecci.
Il suo areale è meno ampio di quello della berta maggiore, giacchè le migrazioni stagionali la portano fino al Mar Nero, partendo sempre dal Mediterraneo, dove trascorre la buona stagione e nidifica. Ma anche la berta minore predilige isole, isolotti e ambienti rocciosi costieri, riparati dalle interferenze umane. E infatti i luoghi prediletti in Italia, dove si ferma per la riproduzione oltre il 60 per cento della popolazione mondiale di berte minori, sono Capraia e altre isole sarde, Montecristo e altri siti dell’Arcipelago Toscano, Lampedusa e l’isolotto flegreo di Vivara. Proprio in Sardegna, a Tavolara, dove pure c’è un’Area Marina Protetta, è concentrata la colonia più numerosa di quegli uccelli con un numero di coppie che è stato valutato ben oltre le diecimila e, secondo alcuni ricercatori, addirittura il doppio.
La cova dell’unico uovo dura due mesi, fatta a turno dal maschio e dalla femmina, e si conclude con la schiusa e la nascita del pulcino, che s’invola nel mese di luglio. Come le altre berte, anche la minore visita il piccolo per nutrirlo solo nella notte, mentre resta fuori per tutta la giornata, fino al tramonto.
Il rituale delle berte al tramonto ispiratore di miti
Quando il sole si abbassa sull’orizzonte, inizia l’avvicinamento ai nidi di centinaia di uccelli che, dopo aver volato per lunghe distanze, si posano sulla superficie del mare, lasciandosi cullare dalle onde, in attesa che faccia buio. Il rituale serale, comune anche alle berte maggiori, vede tutti gli esemplari emettere richiami simili a lamenti di bambini, che riecheggiano forti e laceranti nel silenzio del mare all’imbrunire. Suoni che preannunciano il ritorno ai nidi degli adulti, per nutrire finalmente i pulcini.
Il lamento serale delle berte, che somiglia a richiami in una lingua umana sconosciuta riecheggianti lungo le coste e durante la bella stagione, ovvero dove e quando navigavano gli antichi, è stato collegato al canto mitico con cui le sirene irretivano i marinai, ma che non riuscì a fermare Ulisse. Tanto più che i Greci rappresentavano le Sirene come donne con il corpo da uccello. Nel canto delle berte maggiori, chiamate anche Diomedee come le isole Tremiti, il mito identifica anche i lamenti quotidiani dei compagni dell’eroe della guerra di Troia, Diomede, che, alla misteriosa scomparsa del loro capitano sull’isola di san Domino, furono trasformati in uccelli da Afrodite.
Specie protette in regressione
Da circa mezzo secolo, le colonie di berte sono in progressiva costante regressione ovunque, anche in Italia. Ciò che giustifica e supporta la valutazione negativa dello stato di salute di entrambe le specie che nidificano nel Mediterraneo. Tante le cause di questo trend ormai consolidato, a cominciare dalla perdita di habitat costieri sacrificati all’urbanizzazione. Poi l’inquinamento marino e la pesca intensiva, in particolare di alici, che riducono le risorse ittiche e depauperano i tratti di mare prossimi ai luoghi di nidificazione. Le reti da pesca sono un altro nemico, come gli ami da pesca innescati che spesso vengono ingeriti dagli uccelli portandoli alla morte. Fortissimo è stato l’impatto della proliferazione di ratti neri (Rattus rattus), indotta dall’uomo, sulle isole dove si riuniscono le colonie. Infatti, i ratti si nutrono delle uova e anche dei pulcini, vanificando le covate annuali, con conseguenze pesantissime, tanto che sono partite da qualche anno delle campagne di eradicazione dei ratti da Montecristo e da Tavolara per salvare le generazioni di berte. Anche i gatti inselvatichiti sono predatori sempre più numerosi per le due specie, dichiaratamente vulnerabili. Motivo per il quale sono state inserite nelle Convenzioni di Berna e di Barcellona e sono specie protette dalla Direttiva Uccelli dell’Unione europea, grazie alla quale si sono moltiplicati studi scientifici e campagne di monitoraggio per rilevare la consistenza delle colonie e approfondirne gli elementi di vulnerabilità, per poi elaborare strategie mirate di conservazione.